News — 25 Gennaio 2026
POESIE PER GAZA. QUANDO LA POESIA IMPEDISCE LA SECONDA MORTE
di Nadia Cavalera
“Poesie per Gaza”, l’antologia a cura di Eleonora Bellini e Caterina De Nardi, e a cui ho partecipato anch’io (on line da agosto, ma distribuita in cartaceo solo in questi giorni), non è un libro “sulla guerra”. È un libro dentro la guerra, e soprattutto contro l’anestesia che la guerra, quando si prolunga e si normalizza, produce nelle coscienze. La sua utilità non va cercata nell’originalità dei singoli testi, né in una supposta “qualità media” – criterio inadeguato quando si ha a che fare con un coro – ma nella funzione che l’insieme svolge: trattenere la storia mentre scivola verso l’oblio amministrato.
La prima evidenza, quasi brutale anche se scontata, è lessicale. La parola che domina l’intera raccolta è Gaza. Non come metafora, non come simbolo, ma come luogo insistito, ripetuto, inchiodato. Ripeterne il nome è già un gesto politico: opporsi alla strategia più efficace del potere contemporaneo, che non è la censura ma la saturazione. Gaza, ripetuta, non diventa rumore: diventa ancoraggio. Non permette il passaggio oltre.
Subito dopo Gaza, il campo semantico si restringe drasticamente: bambini, madri, sangue, polvere, macerie, cielo, pane, fame, silenzio. È un lessico primario, quasi elementare. Questa povertà apparente è in realtà una scelta precisa: davanti a un evento estremo, la lingua rinuncia all’astrazione e torna alla sopravvivenza semantica. Qui la poesia non vuole spiegare, vuole far restare.
La sintassi lo conferma. Prevale la paratassi, la frase breve, l’ellissi, l’accumulo. Le anafore (“Mamma…”, “Silenzio…”, “Dove sei Palestina?”), le litanie funebri, gli elenchi ossessivi non sono stilemi ornamentali, ma forme del trauma. La lingua non costruisce architetture complesse perché l’esperienza che tenta di dire è una sequenza di colpi: succede questo, poi questo, poi questo. La poesia registra, come un corpo ferito.
In testi come Notte di Carmela Ippolito, la catena “Mamma – Silenzio – Fumo – La morte” non descrive l’orrore: lo fa accadere nella lingua. In Una scheggia impazzita di Mariella Balla, la frantumazione sintattica – No! la gamba non sento più la gamba… Qualcosa sotto i denti… Sangue” – mima lo shock, non lo rappresenta. La forma qui non abbellisce: testimonia.
Accanto al grido, c’è la cronaca lirica. Testi come Solo polvere di Tiziana Bra o Farina e fumo di Eleonora Bellini mostrano che la poesia, quando vuole essere storica, non ha bisogno di grandi immagini, ma di oggetti esatti: la polvere negli occhi, il peso di un sacco di farina, la fila per il cibo, i droni che “danno la caccia”. Bellini scrive:“Non so dirle nemmeno quanto pesa un sacco di farina / in braccio ad un bambino”.
Qui la poesia tocca un punto decisivo: la guerra come gestione della fame, come controllo del corpo attraverso la logistica.
Il pane – o la sua assenza – ricorre ossessivamente. In Cersosimo, la distribuzione del cibo diventa trappola; in Fiordalisi, promessa fragile (“forse domani troveremo del pane”); in De Vita, la farina è mescolata al sangue e al fango. Il campo semantico del nutrimento è centrale perché Gaza, in questa raccolta, non è solo bombardamento: è amministrazione della sopravvivenza.
Le immagini dominanti – cielo, polvere, sudario, macerie – formano un alfabeto condiviso. Il cielo è quasi sempre ostile: basso, nero, di piombo, “nero-fumo di bombe”. Non consola, non protegge. In Loretta Liberati compaiono “stelle omicide”: il cosmo stesso è contaminato. È una cosmologia capovolta, dove la verticalità non salva più.
E tuttavia, dentro questa materia pesante, la raccolta non rinuncia all’etica. La parola genocidio compare esplicitamente, senza eufemismi. Daniela Larosa scrive: “Genocidio, diamo un nome all’orrore”
Questa insistenza nominale è fondamentale: nominare non è slogan, è atto di responsabilità linguistica. Ecco perché nel mio testo, tramite la voce di un bambino, smaschero l’intero apparato discorsivo adulto e denuncio non solo la violenza, ma il linguaggio che la copre: “difesa”, “complessità”, “danni collaterali”: “Ci chiamano ‘danni collaterali’… / Ma io non capisco.” Nella speranza che la poesia non interpreti, ma demolisca.
Un altro asse forte è quello dell’indifferenza. In Aino, Gaza è “mausoleo dell’indifferenza”; in Casolaro, il grido che entra nelle orecchie obbliga a scegliere: o ascolti, o sei aguzzino. Non c’è neutralità. L’antologia costruisce così una vera e propria etica dell’ascolto: chi non sente, partecipa.
Letta come insieme, Poesie per Gaza funziona come un tribunale senza giudici. Non emette sentenze giuridiche, ma chiama in causa. Interroga chi legge: dove sei mentre accade? Che lingua usi? Che silenzio pratichi?
La sua utilità, allora, non è estetica in senso stretto. È storica. Questo libro serve a impedire la seconda morte: quella che arriva quando i corpi diventano numeri, quando la sofferenza diventa sfondo, quando la parola “guerra” perde peso. La poesia qui non salva, ma resiste all’amnesia.
In tempi in cui tutto spinge a voltare pagina, Poesie per Gaza fa un gesto elementare e radicale: non gira lo sguardo. E costringe chi legge a decidere se restare, o diventare statua di sale.
news correlate

Come si convive con un genocidio
Novembre 01, 2025
Liberarsi dal suprematismo e praticare l’uguaglianza
Settembre 24, 2025
Mario Draghi, il grande abbaglio
Agosto 25, 2025
È tempo di smascherare l’autoassoluzione di Israele
Maggio 25, 2025
Ricordi all’alfabeto, con L.Pignotti e F.Muzzioli
Aprile 12, 2024
Premio alla carriera “L’arte in versi”, 14 maggio 2023
Maggio 14, 2023
Lessico e Cibo Famigliari. Le mie prime cinquemila parole
Giugno 20, 2022
AMICIZIA VIRALE, Roma 25 settembre 2021
Settembre 23, 2021





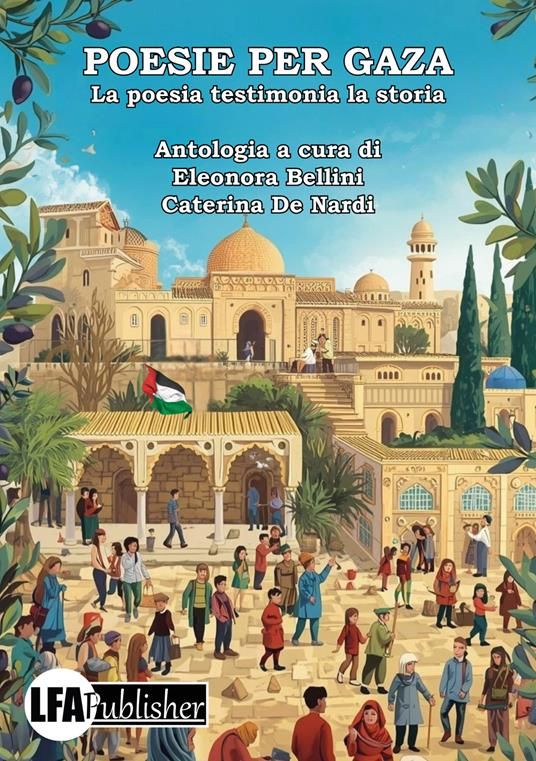











 Scrittora.
Scrittora. 
Commenti recenti